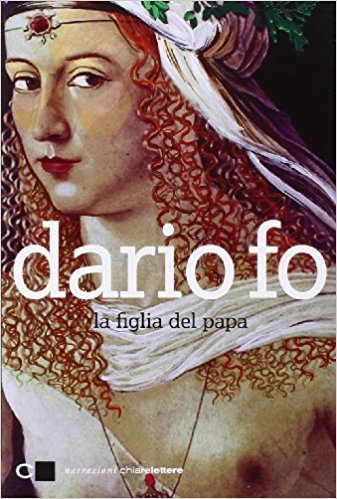Mistero buffo, recensito da davide dotto
Chi ha un po’ di dimestichezza con le canzoni di Giorgio Gaber e di Enzo Jannacci, sa benissimo che esse sono veri e propri pezzi di teatro. Non si assimileranno mai a sufficienza, né diranno tutto quello che hanno da dire se si ignora ciò che si muove in un palco, in un proscenio, nella ribalta. Leggere Mistero buffo senza avere idea della presenza scenica di Dario Fo, è sicuramente un’esperienza minimale, si perde molto. Non per difetto dei pezzi, ci mancherebbe altro, ma perché la nostra inventiva non giungerebbe mai a eguagliare la mimica, la tecnica, l’arte di chi a teatro ci è nato, di chi il teatro se lo porta ovunque. Mistero buffo assomiglia a una partitura musicale e, si sa, molto dipende dall’interprete in grado di impreziosirla o di rovinarla. Vi è un filo rosso che anima le diverse giullarate, un’anima e un nerbo che appartengono al loro autore. Gli appartengono talmente che l’opera non è mai la stessa perché varia, si allunga, si accorcia, si definisce, sviluppandosi in varie direzioni, senza soluzione di continuità. I vari monologhi sono scritti e recitati in un miscuglio di dialetti e di onomatopee (grammelot) cui il giullare ricorreva per farsi capire ovunque si recasse, e tale da raggiungere tutti i vernacoli. Spesso nel medesimo discorso il giullare utilizzava più termini per indicare la stessa cosa, sempre al fine di farsi intendere: "Non me tocar a mi, che mi son zovina [ragazza], son fiola [ragazza], tosa [ragazza] e garzonetta [ragazza]." Altra caratteristica da tener presente, i testi appaiono incastrati uno nell’altro, un po’ come le Metamorfosi di Ovidio. La storia che segue è già dentro quella che precede, lo spettacolo costituisce un monologo unico, senza vere e proprie interruzioni. Cos’è esattamente Mistero buffo? È una rappresentazione sacra che si fa buffa, grottesca, di origine popolare. Diventa, come si chiarirà a breve, strumento di critica sociale, raccontando in primis la storia di un furto, anzi, di una appropriazione indebita. La cultura popolare viene messa da parte, ma non ignorata, semplicemente ci si appropria della sua saggezza levigando le forme, manipolando e adattando le sue creazioni. Del popolo si può, ovviamente, parlare, ma da parte delle persone colte, degli eruditi, dei letterati. Si ricordi in che modo i Fratelli Grimm si siano appropriati delle fiabe tradizionali, di fatto distorcendole. Chi voglia approfondire la questione non ha che da leggere il libro di Jack Zipes, Chi ha paura dei fratelli Grimm? Dario Fo si ribella a un radicato un luogo comune, quello che contesta al popolo la capacità di essere autore di testi, o che essi possano assurgere a qualità letteraria. Anche Dante Alighieri, nel De vulgari eloquientia, marciava sulle stesse corde, Boccaccio invece percorreva altre direzioni. Esempio eclatante è il componimento medievale Rosa fresca aulentissima di Ciullo d’Alcamo. Protagonista della giullarata è un gabelliere che si atteggia a nobile per far colpo su una ragazza, la quale a sua volta si finge figlia del padrone. Il ragazzo tenta di esprimersi in un linguaggio aulico: "Rosa fresca aulentissima ch’apari inver’ la estate/le donne ti disiano, pulzelle e maritate" che è un modo di dire che si trova ancora in Sicilia e il cui significato non ha bisogno di chiose: "Bedda tu si, fighiuzza, che anco altri fighiuzze a tia vurria imbrazzari" La critica sociale, indubbiamente presente nelle giullarate di cui si compone Mistero buffo, parte da qui. Essa si esprime su più fronti, primo fra tutti quello del biasimo rivolto alle istituzioni religiose, più che alla religione: "In tutti i tempi e in tutte le epoche i vescovi stavano dalla parte dei padroni per mettere in croce i poveri cristi" e dove: "Il padre eterno è rappresentativo di quello che i padroni hanno insegnato al popolo, è quello che ha fatto le divisioni, che ha dato terre, poteri, privilegi a un certo gruppo di persone, e invece fastidi, disperazione, sottomissione e umiliazione, mortificazione all’altra parte del popolo". Dio stesso è assimilato ai padroni, quindi odiato, bestemmiato; al contrario del Cristo, amato perché vessato, crocefisso, umiliato e, per ciò, santificato. Ciò è evidente nell’irriverente invito dello stesso Jesus, secondo il racconto reso da un testimone delle nozze di Cana: "Beve’ gente, feit alegria, inchiuchive, imbriaghive, no aspetì dopo, alegria!" Non c’è rassegnazione ai patimenti e alle ingiustizie subite, ma orgoglio ferito e ribellione, come nella madre cui i soldati di Erode hanno ucciso il figlio, prima che la misericordia della follia la invada, antidoto contro un dolore insopportabile (La strage degli innocenti): "Deo tremend e spietàt, – ag criavi – at l’hait comandat ti sto ‘mazement… a t’hait vorsüd ti sto sacrifizi in scambi de fag gni giò ol to fiol: mila fiolìt scanat par vün de ti, un fiüm de sangu par ‘na tasina! T’ol podere ben tegnil in presa a ti sto fiol, se ag dueva costarghe tanto sacrifìzi a nün pover crist…" Credo non ci sia bisogno di traduzione alcuna. La carica emotiva parla da sé. Qui non si fa critica sociale dall’alto di una cattedra o per interposta persona, ma dal basso, attribuendo la parola a chi veramente ne ha diritto, a chi sceglie l’arma del grottesco, del ridicolo e dello stravagante, lasciando emergere passioni altrimenti inespresse. Questo è il cuore di Mistero buffo. I testi, di origine medievale, dialogano alla perfezione con i nostri tempi. Non solo con il Sessantotto, quando sono stati rappresentati la prima volta, ma anche, se non soprattutto, con i nostri giorni. C’è solo una differenza. Se un tempo il popolo rispondeva con il sorriso, la buffonata, lo scherzo e il grottesco per esorcizzare l’ingiustizia di un mondo che a sua volta si faceva beffe di lui (come non pensare alla canzone Ho visto un re?), ora il mondo ha rincarato la dose, perché risponde con la farsa, l’eco di una risata che torna indietro, ingigantita, disperante. Vi è poi, in questi brani, una lucidità di pensiero i cui frutti sarebbero germogliati più tardi, una chiarezza di idee straordinaria cui attingere a piene mani. Qualche esempio. Nella giullarata del cieco e dello storpio (tra il 1200 e il 1300) due compari di sventura tentano, invano, di sfuggire al Cristo, per non essere miracolati e perdere, con ciò, il privilegio di andare a carità ed esser costretti ad andare a lavorare sotto padrone. Altro caso è il testo La nascita del giullare, nel quale si narra della prepotenza di un padrone tiranno e malevolo. Qui la saggezza popolare, lucida e tagliente, continua a stupire: "No te hai capit? I veur coparte e trar via la tera, no i specia altri, lü el debia pür defenderse, no valse meterse a sbragar con loro. Ca ti no t’hait onore, ti set povero, set contadin, vilan, non puoi pensar dignitat, onore, quela è roba par quei che inn sciuri! Ai nobli!"… La cosa è incredibile perché il contadino non deve imitare il padrone, attirandosi addosso una sicura maledizione, ma cacciare, allontanare da sé come un veleno un mondo che non gli appartiene e l’ha vilipeso,tagliato fuori. Così avviene nelle Nozze di Cana, che narra di un iniziale alterco tra chi vuole raccontare una storia: da una parte un ubriaco (popolano), dall’altra un angelo, che potrebbe impersonare il letterato, la persona colta, l’ombra del padrone. La giullarata ripropone su un fronte diverso lo scontro tra due modi di intendere e vedere le cose. Anche qui emerge una saggezza semplice e disarmante, alla quale c’è ben poco da replicare: "«Magna la poma, Adamo!… dolze, bone, dolze, rosse, bone le pome!», basta ca in quel momento ul Adamo ul gh’aves vüt tacat, arenta, un bicerot de vin… uht: l’avrìa catat a pesciade tüti i pomi de la terra, e nüm seresmo tüti salvi in paradiso! O l’è stai lì ol gramo pecat, che i früti no i era stati creadi par esser magnadi, ma par eser intorcicadi, schisciadi: che co le pome schisciade se fa ol bon sidro, coi scirese schisciade s’fai le bone sgnape dolze, e l’uva… l’è un pecat mortale magnarla! Con quela sì dev fa’ el vin!" Concludo ricordando alcuni testi della passione, tra i quali Maria viene a conoscere della condanna imposta al proprio figlio. Maria è per strada con Giovanna quando incontra Amelia, la quale tenta con bugie pietose di distrarla e allontanarla dal luogo della crocifissione del figlio. Sarà Veronica, l’ultima arrivata, in perfetta buona fede a mostrarle il volto del condannato: Maria: «Ol me fiol… ah… a l’è me fiol de mi!» Giovanna: «Co t’è fat… benedeta dona!» Veronica: «Ma mi non credevi ch’a füss la sua mama…de quel!» Maria alla croce è un pezzo recitato da una struggente e indimenticabile Franca Rame, (vedi qui ), che si conclude con un’invettiva contro l’arcangelo Gabriele, colpevole di non averle rivelato il suo dolore di madre. Lo scaccia in malo modo, che ritorni da dove è venuto: "Torna a slargart i ali, Gabriel, torna indré al to bel ciel zojoso che non ti g’ha niente a far chì loga in sta sgarosa tera, in stu turmento mundo. Vaj che no te se sburdéga i ali de piume culurade ‘e zentil culuri… no ti vedi fango e sangu e buagna, mestà e la spüsenta d’partüto?" Maria, santa nel dolore, fiera popolana, si riappropria di ciò che altri hanno inteso sottrarle, come il significato di un dolore che non hanno provato, di cui parlano e non sanno. Nelle ultime battute capiamo il senso genuino di una critica sociale senza tempo e senza luogo, la sola che sia giustificata e abbia ragioni da vendere, che non è denuncia, ma esasperazione di una condizione che per sua natura appartiene a tutti, non al popolo soltanto. La denuncia, se c’è, è rivolta contro chi si chiama fuori, impersonato dall’arcangelo opportunamente allontanato: "Vaj, che no te ne sbreghi i oregi tant delicat co sto criar desasperato e i plangi e ol plorar che crese in omnia parte. Vaj, che ne te se sconsuma i ogi lüminosi a remerar piaghe e croste e bugnoni, e mosche e i vermeni fora dai morti squarciadi. Ti no t’è abitüat, che in d’ol paradis no g’hai rumor ni plangi, né guere, ni preson, ni omeni ni done violade! No gh’è ni fam, ni carestia, njuno che süda a stracabrasci ni fiolì sanza surisi, ni madri smaride e scurade, njun che pensa per pagà ol pecat! Vaj, Gabriel, vaj…" A ben leggere le giullarate, una cosa salta all’occhio. Nessuno pensa a una rivoluzione, di cambiare un ordine destinato a riproporsi tale e quale in perpetuo, anche se in apparenza su altre basi o con altri nomi. Si tratta di una costante nella storia degli uomini che ci restituisce intatti, dopo secoli, i testi raccolti da Dario Fo e Franca Rame. Per la stessa ragione Mistero buffo dagli anni Sessanta è arrivato indenne fino a noi. Se ciò sia un buon segno, non saprei dire. Recensione pubblicata in http://scrittevolmente.com/2013/08/15/approfondimento-mistero-buffo-di-dario-fo/